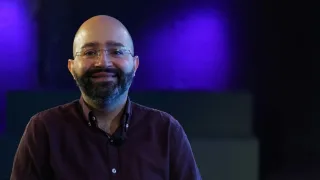C’era una volta la politica secondo Giuseppe Tornatore
Con All’epica. C’era una volta la politica edito da Gruppo Albatros Giuseppe Tornatore ripercorre le tappe di un suo progetto cinematografico non realizzato sul PCI in Sicilia
Nelle 528 dense pagine di All’epica. C’era una volta la politica edito da Gruppo Albatros il regista Giuseppe Tornatore ripercorre le tappe di un suo progetto cinematografico non realizzato che gli sta tuttora molto a cuore. La ricostruzione delle epiche imprese del Partito Comunista Italiano in Sicilia durante il secondo dopoguerra fondata sulle testimonianze dei militanti. Tra essi, Giuseppe Tornatore (1926-2000), il padre del premio Oscar che era stato al centro del film Baarìa (2009).
“I materiali di lavoro dei film non realizzati finivano una volta in un armadio, in un cassetto, oggi in un file nascosto nelle pieghe invisibili di un computer. Ma talvolta diventano un libro. I testi qui pubblicati erano appunto materiali di ricerca per individuare un soggetto cinematografico. Eravamo nel periodo inquieto successivo alla svolta della Bolognina e all’indomani delle prime elezioni politiche prive del simbolo del PCI. Mi ero invaghito dell’idea di fare un film sul mito buono della politica. Fra me e me volevo un po’ rivisitare lo schema di Nuovo Cinema Paradiso. In quel caso, in un’epoca in cui le sale cinematografiche chiudevano a ritmo continuo e la crisi sembrava non si potesse placare, il film aveva raccontato in controtendenza la stagione della nostra vita in cui l’andare al cinema era stato un evento quotidiano irrinunciabile. Un paradigma analogo mi sembrava interessante applicarlo alla politica”.
“In quegli anni, tra il ’90 e il ’93, la politica era diventata, e sarebbe continuata ad esserlo, un simbolo di ignominia. Per la maggioranza della popolazione, non era più quel magnifico strumento per mezzo del quale, trenta, quarant’anni prima, tutti avevano sognato di cambiare il mondo e di cambiarlo in meglio. Pensai dunque che fosse interessante, in un tempo in cui non si credeva più alla politica, raccontare una storia di personaggi che proprio nella politica credevano profondamente come unica possibilità di riscatto, di edificazione di un futuro migliore, per sé stessi e per i propri figli. Da tale premessa, muoversi fu facile. Sin da ragazzo ero stato nutrito da racconti su quell’epoca. Grazie a mio padre avevo seguito e conoscevo la vita del Partito. Il PCI, che è diverso dal comunismo. Molte cose le sapevo, ma si trattava di distillarle in una storia, un soggetto”.
“Mi immersi nella lettura dei testi che fu possibile rintracciare. Ma soprattutto mi venne spontaneo ricorrere a incontri con persone che, data l’età, avevano fatto a tempo a vivere quel periodo avventuroso della nostra vita politica regionale e nazionale. E quindi cominciai a incontrarle e a farmi raccontare in modo non ordinato, anzi discontinuo, le loro storie e una certa aneddotica, per raccogliere anche piccole cose, piccoli gesti, talvolta soltanto delle parole, singole immagini utili a tenere in piedi la trama che stavo inseguendo. Andai in Sicilia per diversi giorni e incontrai ex dirigenti del partito, del sindacato, militanti, storici, tipografi, giornalisti, sindaci, critici d’arte. Insomma, a tessere tutto quello che mi era possibile attraverso le conoscenze personali mie, di mio fratello, di mio padre: uno dei tanti che mi raccontò un sacco di cose. Le memorie che ottenni non dovevano avere cittadinanza letteraria, di nessuna natura. Dovevano servire ad arricchire la mia capacità di elaborare una narrazione. Il concepimento ebbe luogo. Chiamai a collaborare con me Gianni Riotta. Sentivo che una storia come quella non potesse essere frutto di un lavoro solipsistico, come in altri film avevo ritenuto più congeniale. Lo chiesi a lui perché aveva scritto un libro che mi era molto piaciuto, perché lo conoscevo e sapevo quanto fosse appassionato di quella materia. Infatti fu un rapporto fruttuoso, bello”.
“Scrivemmo un soggetto. Che in un primo momento si chiamava Ad ogni buon conto o A ogni buon conto. Andavo in crisi per quella ‘d’. Poi, proprio intervistando e ricordandomi delle tante storie di quando ero ragazzo, mi venne in aiuto il nostro dialetto suggerendomi un altro titolo: All’èpica. Da cosa nasceva? In dialetto siciliano, almeno dalle mie parti, per dire ‘all’epoca’ diciamo ‘all’ìebbica’. Una curiosa riscoperta. Ma non ho indagato in chiave etimologica, non ho condotto alcuno studio, mi sono basato sul mio bagaglio personale (…) Un filo che lega un po’ tutte queste narrazioni è il senso della grande illusione. Proprio la grande illusione. Molti l’avevano già capito prima, molti lo avevano intuito durante, però all’inizio degli anni ’90 finalmente lo si può dire, e lo dicono. Gli intervistati usano una fraseologia che quindici anni prima non avrebbero utilizzato, mai, in nessuna intervista e men che meno in un intervento in uno dei vari momenti di vita di una forza politica o sindacale. Quello è l’attimo invece in cui tutti sanno trovare, nella svolta che si stava consumando, la lente di ingrandimento e la distanza ideale per dire cose che non si erano mai dette. E cioè che certi sogni, certi punti di riferimento, certe utopie non era possibile tenerle in piedi”.
Tra i diciotto intervistati nel volume, Fabio Rinaudo (1931-1977), critico cinematografico, giornalista, sceneggiatore, diplomato in regia al Centro Sperimentale, e in seguito attivissimo braccio destro del produttore Franco Cristaldi e strettissimo collaboratore del regista napoletano Francesco Rosi. Questo personaggio indimenticabile del cinema italiano accenna nel volume alle esperienze sull’epico Salvatore Giuliano diretto da Rosi in Sicilia. Nel 2018 Giuseppe Tornatore aveva pubblicato da Sellerio un altro suo progetto non realizzato, Leningrado.
Editoria
Emanuele Rauco esordisce in narrativa, tra Kitano e Suleiman
Il critico e giornalista è in uscita con ben tre testi, due saggi e una raccolta di racconti
“Percepire, esplorare, avventurarsi”: un nuovo volume su Stan Brakhage
È disponibile online e in libreria dall’11 marzo ‘Percepire‘, esplorare, avventurarsi. Introduzione al cinema sperimentale di Stan Brakhage, monografia firmata da Cristiano Bellemo e pubblicata da Cinematografo Edizioni nella collana...
‘Solo ossa’ & ‘Nosferatu’: vampiri per grandi e piccini
Il 1° gennaio sarà in sala l’attesissimo Nosferatu di Robert Eggers. Per l’occasione Luca Ruocco, già giornalista, critico, attore teatrale, fumettista e organizzatore del Fantafestival, da dato seguito al suo libro vampiresco per ragazzi ‘Denti da latte’
Disponibile ‘Il Giro dell’horror’ in formato DVD + Libro
Ispirato da sogni bizzarri, Luca Ruocco (già tra gli organizzatori del Fantafestival, scrittore e giornalista) ha ideato una docu-serie che esplora il mondo della cultura horror italiana. Con la regia di Paolo Gaudio e un team di collaboratori stravaganti, Il Giro dell’Horror supera rocamboleschi imprevisti, come querele inattese, rapimenti e persino viaggi nel tempo, per completare una prima stagione che racconta le carriere di tre icone del genere: il regista Domiziano Cristopharo, il compositore Fabio Frizzi e il maestro del terrore Lamberto Bava

;)
;)